“Cena con narrazione”: una serata di “intrecci” tra mani che lavorano e parole che raccontano
Giovedì scorso, al Santuario, si è svolto il secondo appuntamento dell’edizione 2025 della “Cena con narrazione”: quella vissuta insieme dai numerosi partecipanti, provenienti da tanti luoghi diversi, è stata una serata di “intrecci”. Come quelli, spiegati, e mostrati in diretta, da Silvia Di Iacovo e Luigina Zazzetta, che sono alla base della realizzazione dei cesti, un’arte antica, e maschile, di pazienza, di abilità, di ascolto e lentezza e anche di conoscenza e di cura del creato, soprattutto delle sue piante; ma anche come gli intrecci esistenziali raccontati da Andrea Marangoni, Responsabile dei servizi socio-educativi dell’Associazione Piombini-Sensini ETS di Macerata, che inaspettatamente ti portano a incontrare le storie di altri, provenienti da città, esperienze e perfino paesi diversi, e a scegliere di fare un tratto di strada con loro. Intrecci che sono anche incontri e accoglienza reciproca tra generazioni, se è vero, come dice il profeta Gioele, con una frase che dava il tema all’incontro, “io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni”.
I sogni degli anziani sono riecheggiati nella mente di Luigina quando, nel 2018, “dopo aver letto un post su Facebook in cui veniva pubblicizzato l’inizio di un corso di cesteria a Grottammare, ho sentito accendersi in me il desiderio di un antico mestiere che avevo visto fare da mio nonno e da mio padre. Non so dirvi cosa mi abbia spinto, in fondo era un’arte praticata dagli uomini in ambiente agricolo, in un periodo dell’anno in cui in campagna c’era poco da fare, che spesso si mettevano nelle stalle dove il calore degli animali faceva da termosifone. Non ricordo che mio padre e tantomeno mio nonno, burbero dalla nascita, mi abbiano mai invitato a provare, io l’ho solo visto fare, ma quel fare era ricco di passione, la stessa passione che in un momento del tutto inaspettato mi ha spinto a provare: però non potevo provare da sola e quindi da subito ho invitato Silvia a partecipare a questo corso di cesteria, una mia vicina di casa e amica”. Nel loro cammino Luigina e Silvia hanno incontrato il maestro Franco, un novantenne fantastico: “possiamo dire grazie alla sua passione per il bello, ha una pazienza infinita, è un uomo capace di cura e di precisione, e ogni cosa che realizza è fatta a regola d’arte. Si rallegra quando i suoi allievi lo imitano alla perfezione, ma è anche molto schietto. Quando le cose vengono fatte in modo frettoloso e raffazzonato, lui ce lo dice tranquillamente che quella cosa fa schifo. Però noi accettiamo anche la sua critica, perché vediamo tutta la passione che ci mette e quindi noi, da bravi allievi cerchiamo di impegnarci al massimo e fare sempre meglio. Questo va a testimonianza che la forza carismatica e misteriosa del come viene trasmesso è più importante di quello che viene trasmesso”.
E chissà quali sogni e passioni hanno spinto Andrea, e la moglie Roberta, genitori dei sei figli e nonni di due nipoti, a fare la scelta radicale, nel 2001, quando era nato da un mese il quarto figlio, di andare ad abitare in un edificio in cui da tanti anni a Macerata si accolgono bambini, bambine, ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà familiari. L’associazione attualmente ha quattro comunità residenziali per minorenni, vari servizi territoriali di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, 25 educatori, tre psicoterapeuti e due mediatori familiari. Andrea ricorda che tutto è partito da un incontro che lo ha cambiato, quello “con un bambino autistico che ho cominciato a seguire in una scuola e che mi ha aperto, diciamo così, un po’ il sentiero verso una professione di aiuto nell’ambito dei servizi sociali, educativi, anche sanitari”. Una scelta che è stata determinata anche da una dimensione “ineludibile” della vita di Andrea e Roberta, quella “spirituale”, vissuta “attraverso la nostra esperienza di fede, con una comunità di fratelli, nella famiglia e con i figli, che ci ha dato il senso dello stare e del rimanere lì, dove vi assicuro, ne abbiamo viste e vissute di tutti i colori, sia sul piano personale che con i nostri figli e con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che arrivavano. Un nostro vecchio formatore psicoterapeuta diceva sempre che per accompagnare questi bambini o queste bambine, anche nelle elaborazioni dei loro traumi, bisogna essere disposti ad andare all’inferno e tornare con loro”. “Il nostro compito – ha sottolineato Andrea – è dare speranza nonostante tutto, anche se la storia è difficile. E la speranza, come afferma San Paolo, nasce dalla tribolazione, attraverso la pazienza e la virtù provata. Papa Francesco diceva che oggi fuggiamo dalla sofferenza, ma non possiamo evitarla: bisogna attraversarla, come il trauma. Questo aiuta a riprendere il volo. I ragazzi hanno bisogno di ali, di fiducia. Essere genitori oggi è difficilissimo. Noi vediamo la parte meno funzionante della genitorialità. Ma le neuroscienze ci dicono che per crescere bene, un bambino ha bisogno anche solo di quei pezzi che funzionano nei genitori, pur se pochi. Riconoscerli è importante. Anche se una mamma ha una malattia mentale o un padre ha problemi con la giustizia, hanno pur sempre tentato di dare qualcosa. Per questo serve una comunità che aiuti le famiglie. Non servono Scuole per genitori, ma vicinanza reale, aiuto concreto. Una mamma oggi ha lasciato il figlio da noi con un borsone, esausta. Ha detto: Tenetelo voi, io non ce la faccio più.”
Ma come si fa a resistere a tanta pressione, a tanto dolore? Andrea ha raccontato che “in questi anni, quello che ci ha salvato è il gruppo. Perché se lavori ogni giorno con la sofferenza, rischi di ammalarti. Il gruppo è l’unica barriera che ci protegge dal fuoco incandescente della rabbia, della disperazione. Il gruppo permette di metabolizzare i vissuti, di condividerli, di trovare conforto – cioè forza comune. Da soli si fa poco. Per questo serve una comunità educante. È inutile rimpallare responsabilità tra famiglia, scuola e genitori. Noi lavoriamo molto sul territorio proprio per connettere, non per competere. Purtroppo oggi tutto è competizione. Parliamo tanto di inclusione, ma ‘inclusione’significa chiudere dentro, e implica che noi siamo il modello da raggiungere. Invece serve connessione: costruire passaggi, incontrarsi a metà. Anche con l’immigrazione: parliamo di integrazione, ma è un concetto etnocentrico. Noi incontriamo madri afgane, africane, che hanno culture ricchissime. Ma vogliamo integrarle, cioè trasformarle in occidentali. Invece serve interazione: tu e io, non o tu o io”. Certo “è difficile trovare giovani disposti a condividere questo cammino. Anche per la retribuzione e perché il lavoro è totalizzante. I bambini lo percepiscono subito. Ti chiedono simbolicamente: Tu, che vuoi fare con me? Vuoi essere mio padre, mio fratello maggiore, un compagno di giochi? E non conta tanto il titolo di studio, ma chi sei tu”.
Molte sono state le domande rivolte ad Andrea su come sia riuscito a conciliare la vita familiare personale con la scelta di vivere in un luogo di accoglienza. La sua risposta è che se da una parte “i nostri figli hanno sviluppato una sensibilità forte”, dall’altra “ho perso dei pezzi della loro vita. Ma questo perché non sono riuscito a separare bene il lavoro dalla vita privata. Vivendo lì dentro, non c’è distacco. È come se lavorassi sempre. Anche se oggi l’organizzazione mi protegge di più. Ma partecipiamo sempre alle gioie e ai dolori quotidiani. E quando la comunità è educante, non può non entrare in contatto con il dolore. Noi, con il comune, con i salesiani, con altre associazioni, abbiamo creato un Tavolo della Buona Accoglienza per aiutare le famiglie anche con cose semplici: portare un figlio a calcio, aiutarlo nei compiti, riportarlo a casa. Serve fiducia negli altri. Serve costruire relazioni vere. Gli stessi educatori dicono che hanno ricevuto molto di più di quanto hanno dato”. Qualcuno ha chiesto quale ingrediente, oltre alla fiducia, serve per sostenere i giovani: Andrea ha ammesso che “è complicato. Oggi conta se funzioni, se hai follower. Ma la maggior parte di noi vive di fragilità. Speriamo che anche i fallimenti possano essere occasione di rinascita, perché se no, l’unico modo per farsi ascoltare è il dolore: sbronze, tagli, sostanze. Una ragazza diceva: quando esce il sangue dalle braccia, la mia ansia si calma. Viviamo in una società dove la funzione paterna è evaporata. Il padre rappresentava la legge, non le regole – quelle ce ne sono tante. Ma la legge interiore, che permette di vivere socialmente. Oggi vige il principio del perché no? e non c’è più la capacità di rinunciare. La figura paterna dovrebbe alimentare il desiderio: in generale gli adulti devono aiutare i giovani a trovare senso, a porsi le grandi domande: chi sono? Dove vado? Perché vivo? E, poi, lasciarli andare”.
Simona Mengascini









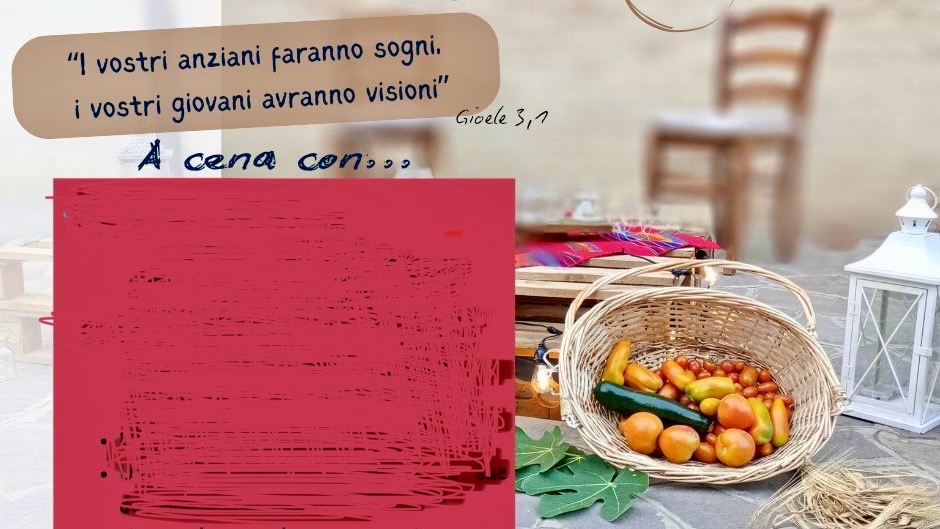

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.